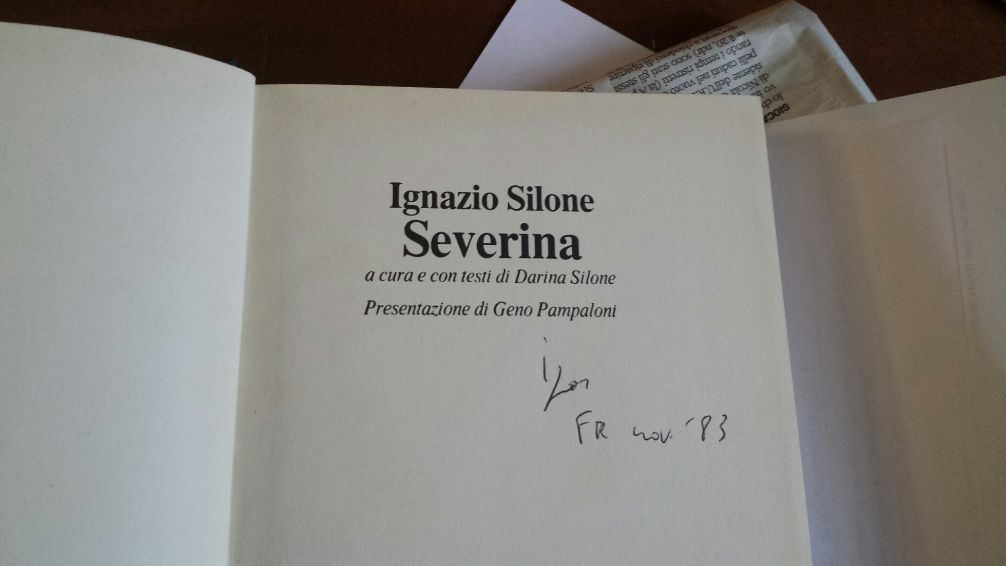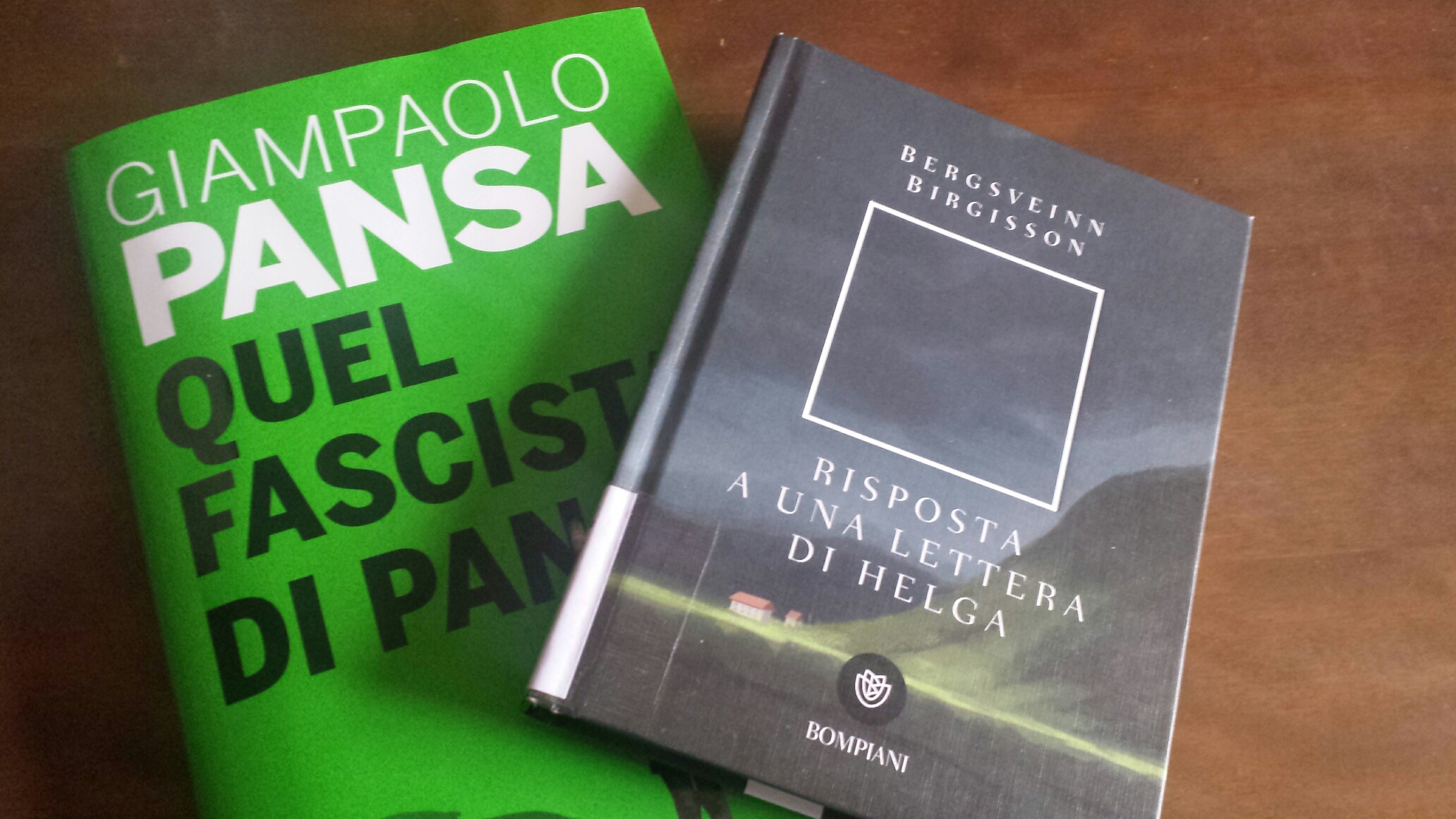Non vedevo l’ora che papà si alzasse dalla poltrona del salotto, non tanto per appropriarmi di quello spazio – preferivo le meno prosaiche ma più appartate scale condominiali che portavano al grande terrazzo che sovrastava i tetti degli altri edifici e che noi bambini avevamo eletto a torre di guardia per guerre mai combattute ma sempre vinte – quanto piuttosto perché quello era il segnale giusto: aveva finito di leggere il giornale, quindi… toccava a me! Ed eccoli, gli immensi fogli de “Il Tempo”, non più intonsi, ma neppure troppo sgualciti, che iniziavo a divorare dalla prima all’ultima pagina, dal primo all’ultimo articolo, senza perderne neppure uno, anche se certi argomenti erano per me astrusi. Era quello il giornale che allora – a conti fatti, siamo a 45 anni fa – entrava in casa. E che ho letto anche io per tanti anni dopo. Allora non ne conoscevo “l’orientamento politico” e neppure mi interessava: mi bastavano (anche se in realtà non mi bastavano mai) gli articoli di cronaca, la terza pagina, gli spettacoli e lo sport, la rubrica del “disco rosso”, il “Così, semplicemente” di padre Rotondi, le recensioni di Rondi, gli editoriali di Gianni Letta (a proposito, qualche giorno fa l’ho incontrato a L’Aquila, l’ho ringraziato per quel periodo e quel giornale e l’ho visto perfino un po’ commosso nel ringraziare lui a me).
Nelle lunghe estati nella casa di campagna di nonna Maria, dietro la cantina era il luogo ideale per nascondermi, con “Il Tempo” (nonna si sobbarcava lunghi tragitti a piedi fino al paese, per la spesa di ogni giorno ma anche per prendere il giornale a quel nipote che rompeva la solitudine di vedova troppo giovane e la faceva ridere con i suoi scherzi) e un manico di scopa: quello era il microfono, e io ero l’inviato di un tg mentre leggevo le cronache del giornale da Paesi lontani. Forse è lì e allora che ho desiderato fare il giornalista da grande; sicuramente è su quelle pagine che ho imparato i primi ma essenziali rudimenti della professione.
Poi gli anni sono passati. Ed è cambiato “Il Tempo” e sono cambiato anch’io, con i miei gusti editoriali, insieme al mondo dei giornali. Non faccio difficoltà ad ammettere che per un lungo periodo quel giornale non l’ho più riconosciuto, e quindi letto ancora di meno. Ma, al… tempo stesso, mi sono di nuovo un po’ emozionato – ed ecco perché scrivo queste misere righe di ricordi – quando stamane ho appreso delle novità grafiche del Tempo: un giornale che si rifà il vestito, che ne indossa uno nuovo, è perché vuole (ri)uscire tra la gente e fare bella figura.
La copia di oggi ce l’ho qui accanto, la sto compulsando da stamane, e “il nuovo” già si vede, si legge.
E, per quello che conta, faccio i migliori auguri al direttore Franco Bechis (nessuna captatio benevolentiae: ci saremmo visti sì e no un paio di volte e di certo neppure si ricorderà di me) perché questo nuovo vestito possa attrarre tanti lettori… Proprio come quel papà sprofondato nella sua poltrona e quel bambino col manico di scopa come un microfono.